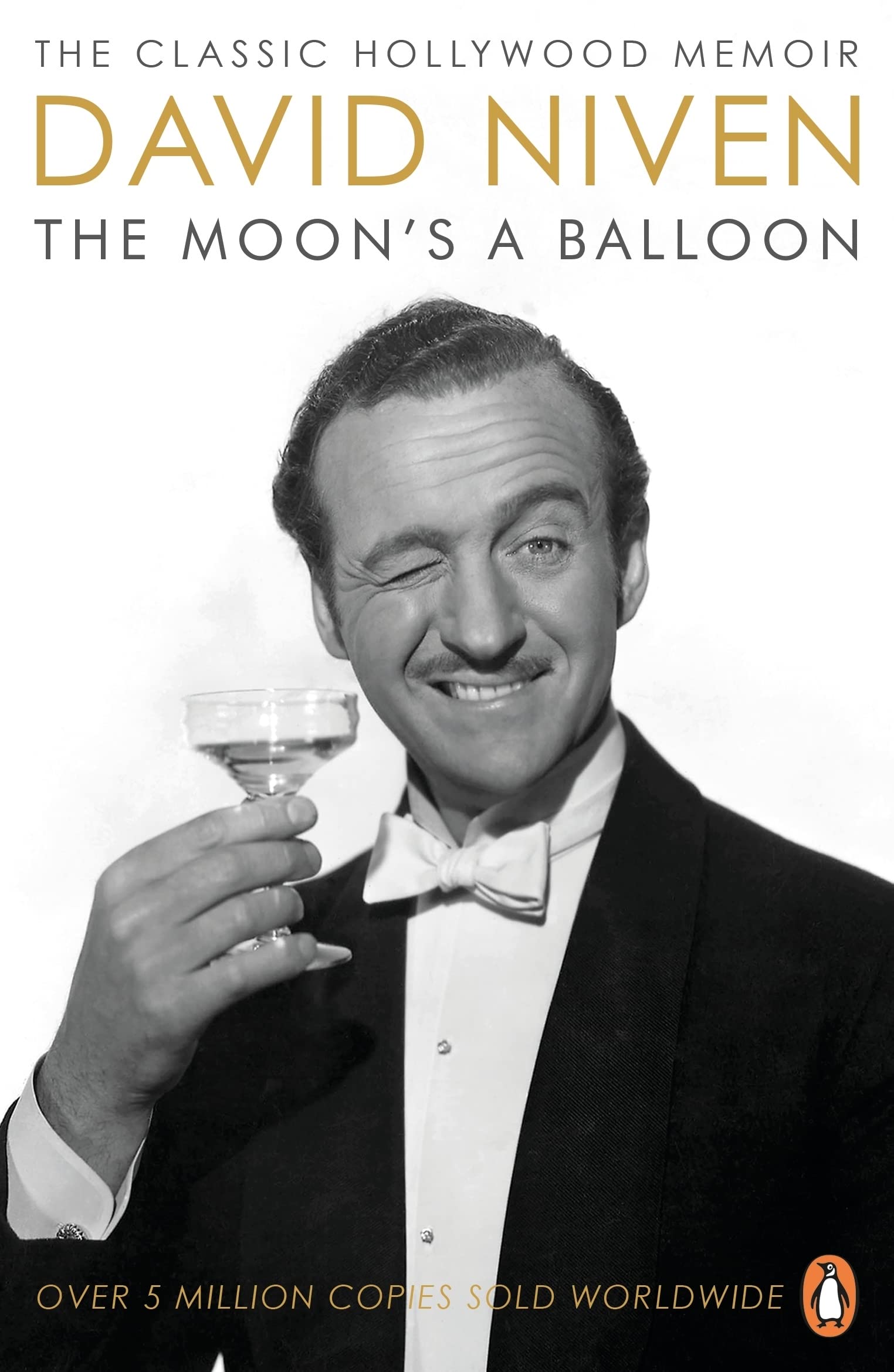Il 28 gennaio 1985, nella lunga notte che seguì gli American Music Awards, l’élite musicale statunitense si riunì negli studi A&M di Los Angeles per incidere “We Are the World”, il brano di beneficenza destinato a raccogliere fondi per l’Etiopia. Produttori, etichette e media non avevano dubbi: doveva esserci anche Prince. La sua presenza avrebbe aggiunto prestigio, potenza artistica e visibilità al progetto USA for Africa. Eppure, una delle figure più rivoluzionarie del pop scomparve dalla scena proprio quando l’evento stava per entrare nella storia.
Dietro quella scelta, rimasta celebre quanto enigmatica, non si nasconde un solo motivo, ma un intreccio di fattori in cui carattere, rivalità artistica, controllo creativo e pressione dell’industria si fondono in un ritratto lucido della complessità di Prince.
Dopo aver vinto diversi premi, Prince salutò la platea degli AMA e lasciò la venue. In quello stesso momento, Lionel Richie e Quincy Jones coordinavano un cast stellare: Michael Jackson, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, tra gli altri. La registrazione di “We Are the World” era una chiamata al dovere collettivo.
Prince però non si presentò agli studi. Preferì dirigersi al Carlos ’n Charlie’s, un club di West Hollywood. Un gesto volutamente distante dall’immagine di artista collaborativo che la serata voleva trasmettere.
Il rapporto tra Prince e Michael Jackson era carico di competizione. Entrambi innovatori, entrambi desiderosi di dominare il pop, entrambi perfettamente consapevoli del proprio valore nell’industria musicale.
Prince non voleva essere “una voce nel coro”. La sua identità artistica era forgiata sulla totale autonomia, sull’unicità e sulla ricerca di un’espressione che sfuggisse a qualsiasi conformismo. Essere inserito in un prodotto corale, con una struttura rigida e parti vocali assegnate, rappresentava un vincolo insopportabile per un perfezionista abituato a controllare ogni nota del proprio mondo creativo.
Prince si dichiarò disponibile a partecipare solo se gli fosse stato concesso di incidere un assolo di chitarra in una stanza separata, lontano dalla registrazione collettiva. Quincy Jones — che con Michael Jackson aveva appena costruito il fenomeno Thriller — respinse la proposta. Per il produttore, la potenza mediatica di We Are the World stava nella sua immagine: gli artisti uniti fisicamente e simbolicamente contro la fame nel mondo.
Prince non tornò sui suoi passi.
Il posto vocale che gli era stato ipoteticamente considerato fu affidato a Huey Lewis, che affrontò con professionalità quella che molti interpretarono come una “parte da Prince”.
L’assenza fu duramente criticata da media e colleghi: venne definita egoistica, stravagante, persino irresponsabile rispetto alla causa benefica. Ma il contesto racconta un’altra verità:
Prince ha donato brani originali a scopo benefico in altri contesti.
Dopo Purple Rain, era immerso nella produzione della colonna sonora di Around the World in a Day.
Non tollerava le pressioni dell’industria e i tentativi di incasellarlo.
Per chi conosce la sua arte, la decisione non stupisce: Prince non seguiva mai il copione degli altri.
Oggi, con un clima culturale in cui gli artisti vengono giudicati anche per la loro immagine pubblica e adesione a movimenti collettivi, la storia di quella notte del 1985 appare ancora più attuale. Prince rivendicò la libertà creativa davanti alla più massiccia iniziativa musicale del tempo. Non smise mai di essere un lupo solitario, anche quando il mondo avrebbe voluto vederlo al centro della folla.
Prince non cantò in “We Are the World” perché non poteva comprometterne il principio sacro: essere se stesso, alle sue condizioni. Quella scelta divenne un tassello fondamentale nella costruzione del suo mito: l’artista che, pur ammirato da tutti, non apparteneva a nessuno.
È una storia che insegna che anche l’assenza può parlare più
forte di una nota cantata.
E che alcune leggende non si
definiscono per ciò a cui partecipano, ma per ciò da cui scelgono
di restare fuori.